A Venezia verrà presentato in concorso “Saint Omer”, il primo film della documentarista Alice Diop. Peccato che il documentario più recente, noto e premiato di Alice Diop sia di gran lunga il più debole, accostarsi a questa autrice con “Nous”(2021) non rende giustizia alla sua produzione precedente, della quale prendiamo in considerazione tre esempi:
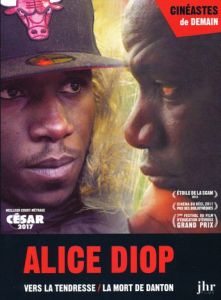 -Il notevole “Vers la tendresse” racconta il disagio giovanile di quattro ragazzi delle banlieu parigine: l’attrazione verso puttane e donne problematiche, l’omosessualità, la dipendenza come compensazione di una necessità emotiva, l’incapacità di conoscere l’amore così come è concepito, a livello culturale, dai francesi bianchi. Illustrato in maniera impressionista, con le voci dei protagonisti sempre fuori campo, mentre li vediamo che vagano nella notte. Solo una sequenza stona profondamente, e merita una riflessione a parte***, ma non inficia assolutamente il valore dell’opera.
-Il notevole “Vers la tendresse” racconta il disagio giovanile di quattro ragazzi delle banlieu parigine: l’attrazione verso puttane e donne problematiche, l’omosessualità, la dipendenza come compensazione di una necessità emotiva, l’incapacità di conoscere l’amore così come è concepito, a livello culturale, dai francesi bianchi. Illustrato in maniera impressionista, con le voci dei protagonisti sempre fuori campo, mentre li vediamo che vagano nella notte. Solo una sequenza stona profondamente, e merita una riflessione a parte***, ma non inficia assolutamente il valore dell’opera.
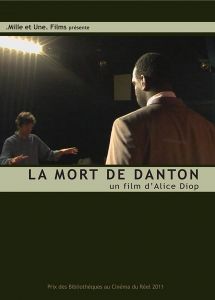 -La storia del protagonista di “La mort de Danton”, un giovane nero proveniente da un quartiere malfamato, che frequenta una famosa scuola di recitazione per divenire attore, è un importantissima voce, perché racconta dell’insormontabile divario tra differenti realtà sociali. Attraverso le sue riflessioni, aspettative, e il rapporto con i compagni del corso, francesi bianchi e privilegiati, emerge il senso di diversità che si confonde alla frustrazione di chi percepisce, non nei singoli, ma nell’ambiente stesso, un sottile e strisciante sentimento discriminatorio.
-La storia del protagonista di “La mort de Danton”, un giovane nero proveniente da un quartiere malfamato, che frequenta una famosa scuola di recitazione per divenire attore, è un importantissima voce, perché racconta dell’insormontabile divario tra differenti realtà sociali. Attraverso le sue riflessioni, aspettative, e il rapporto con i compagni del corso, francesi bianchi e privilegiati, emerge il senso di diversità che si confonde alla frustrazione di chi percepisce, non nei singoli, ma nell’ambiente stesso, un sottile e strisciante sentimento discriminatorio.
 -“La permanence” (On Call, 2016), in assoluto l’opera più riuscita, si basa su un’unica idea, molto semplice: in uno studio medico della banlieue parigina di Bobigny, un medico riceve quotidianamente decine di rifugiati, che necessitano di certificati, medicinali, permessi. La camera fissa inquadra i loro volti, mentre parlano con il dottore, raccontano, implorano, si disperano, sorridono malinconicamente, tutti estremamente confusi e spaventati, alcuni traumatizzati in maniera irreversibile, condannati da un passato dal quale non possono più salvarsi. Il medico parla loro con una voce distaccata ma empatica, spesso consapevole che quello che sta facendo non è altro che un palliativo. Il documentario è tutto qui, non si esce mai da quella stanza, si tratta in assoluto dell’opera meno elaborata, e rimane la migliore.
-“La permanence” (On Call, 2016), in assoluto l’opera più riuscita, si basa su un’unica idea, molto semplice: in uno studio medico della banlieue parigina di Bobigny, un medico riceve quotidianamente decine di rifugiati, che necessitano di certificati, medicinali, permessi. La camera fissa inquadra i loro volti, mentre parlano con il dottore, raccontano, implorano, si disperano, sorridono malinconicamente, tutti estremamente confusi e spaventati, alcuni traumatizzati in maniera irreversibile, condannati da un passato dal quale non possono più salvarsi. Il medico parla loro con una voce distaccata ma empatica, spesso consapevole che quello che sta facendo non è altro che un palliativo. Il documentario è tutto qui, non si esce mai da quella stanza, si tratta in assoluto dell’opera meno elaborata, e rimane la migliore.
Solitamente lo stile della Diop è asciutto ed efficace, ogni tanto si sofferma su uno scorcio particolarmente suggestivo, o su di un volto in silenzio, ma mai più del dovuto, le immagini sono al contempo necessarie ed accessorie, al centro vi è sempre il pensiero e la testimonianza di chi guarda la società umana come qualcosa di lontano ed impossibile da raggiungere. Se analizziamo invece l’ultimo lavoro della Diop “Nous”, troviamo una serie di sperimentazioni formali e derive verso una new wave stilistica fatta di immagini statiche che lasciano intravedere suggestioni retoriche e didascalismo. I protagonisti non sembrano più così interessanti, e l’urgenza delle loro storie non così vitale, la stessa regista si mostra e mostra filmati della sua famiglia, in bilico tra il racconto intimista e lo spaccato sociale, l’intervento per la prima volta di una, anzi due, voci fuori campo, con intento lirico illustrativo, rendono il lavoro leggermente pretenzioso, e lo privano della carica eversiva e della purezza necessaria a trattare in maniera efficace la materia. Si fatica ad arrivare in fondo.
Se analizziamo invece l’ultimo lavoro della Diop “Nous”, troviamo una serie di sperimentazioni formali e derive verso una new wave stilistica fatta di immagini statiche che lasciano intravedere suggestioni retoriche e didascalismo. I protagonisti non sembrano più così interessanti, e l’urgenza delle loro storie non così vitale, la stessa regista si mostra e mostra filmati della sua famiglia, in bilico tra il racconto intimista e lo spaccato sociale, l’intervento per la prima volta di una, anzi due, voci fuori campo, con intento lirico illustrativo, rendono il lavoro leggermente pretenzioso, e lo privano della carica eversiva e della purezza necessaria a trattare in maniera efficace la materia. Si fatica ad arrivare in fondo.
Ora, per la prima volta, la regista si cimenterà con un film,e non un documentario. Se si libererà dei vezzi emersi nell’ultimo lavoro e ritroverà l’immediatezza di sguardo che gli è propria, possiamo ben sperare.
***Ad un certo punto la regista indugia, mostrando una giovane coppia che conversa, e si bacia teneramente, ma poi si spinge oltre, e quei cinque minuti di “petting” spezzano irrimediabilmente l’equilibrio di un mediometraggio altrimenti perfetto. Prima potevamo guardare le immagini dimenticandoci che sono immagini “offerte” ad un obiettivo, dimenticando che un documentario non è quasi mai qualcosa di “naturale” come crediamo, che sin dai tempi di Nanook l’eschimese, il documentario è sempre stato “sceneggiato”.
Bazin parlava dell’irrappresentabilità della morte e dell’amore nel cinema. E diceva che “due momenti della vita sfuggono radicalmente a questa concessione della coscienza: l’atto sessuale e la morte”, perché “l’uno e l’altro sono alla loro maniera la negazione assoluta del tempo oggettivo: l’istante qualificativo allo stato puro”; aggiungendo che “come la morte, l’amore si vive e non si rappresenta, o almeno non lo si rappresenta senza violazione della sua natura.
Ora, il problema di “rappresentare” l’atto sessuale è stato affrontato e in qualche modo superato dal cinema di finzione. Ma mostrare, a livello documentaristico, una scena di intimità tra due persone ci riporta immediatamente al ruolo di voyeuristi e trasmette troppo vivamente l’impressione che i due sullo schermo stanno recitando per noi, dunque, è rappresentato o reale? Non possiamo credere che sia vero, perché, se lo facessimo, rimarremmo inorriditi dalla violazione che la presenza di una telecamera produce documentando un momento di tenerezza intima.
Qui si gioca con una sacralità dalla quale è difficile uscire indenni. Non ci viene richiesta la “sospensione dell’incredulità”, bensì si esige che la nostra percezione sia reale. Il cortocircuito è inevitabile.


